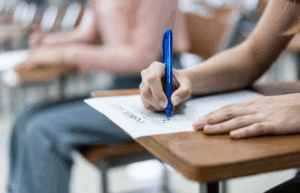Sanità territoriale: come stanno cambiando i servizi vicino a casa
Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di sanità territoriale, Case della Comunità, assistenza domiciliare e telemedicina. Non sono solo nuove etichette, ma il segno di una trasformazione profonda del Servizio Sanitario Nazionale, che punta a spostare una parte importante delle cure fuori dall’ospedale, il più possibile vicino alle persone e alle loro case.
Questa evoluzione è spinta anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare dalla Missione 6 – Salute, che dedica risorse importanti al potenziamento dei servizi territoriali, alla digitalizzazione e alla presa in carico più equa dei cittadini.
Vediamo quindi che cosa sta cambiando, quali nuove strutture stanno nascendo e cosa questo significa concretamente per chi vive in città, in provincia o nelle aree interne.
Che cos’è la sanità territoriale (e perché è così importante)
Per sanità territoriale si intende l’insieme di servizi sanitari e socio-sanitari che non si svolgono in ospedale, ma sul territorio: ambulatori, consultori, servizi di igiene pubblica, assistenza domiciliare, strutture intermedie e, sempre di più, servizi digitali e di telemedicina.
L’obiettivo è duplice:
- ridurre la pressione sugli ospedali e sui pronto soccorso, garantendo che arrivino in reparto solo i casi che davvero ne hanno bisogno;
- prendersi cura in modo continuativo delle persone, soprattutto di chi ha patologie croniche, è fragile o vive in contesti isolati.
La pandemia ha mostrato in modo evidente i limiti di un sistema troppo incentrato sull’ospedale e ha accelerato il dibattito sulle cure di prossimità. Da qui la scelta di investire su nuovi modelli organizzativi, più vicini alla comunità e integrati con i servizi sociali.
Le nuove strutture: Case della Comunità, Ospedali di Comunità e COT
Uno dei cambiamenti più visibili è la nascita (o trasformazione) di nuove strutture territoriali.
Case della Comunità
Le Case della Comunità sono pensate come il punto unico di accesso a molti servizi di prevenzione, cura e riabilitazione: qui dovrebbero trovare spazio medici di medicina generale, pediatri, infermieri di famiglia, specialisti, servizi sociali e sportelli di orientamento.
Funzionano come anello intermedio tra gli ambulatori dei medici di famiglia e l’ospedale, con l’obiettivo di:
- prendere in carico in modo coordinato i pazienti, soprattutto cronici e fragili;
- evitare “rimbalzi” da un ufficio all’altro;
- offrire servizi anche in orari più ampi rispetto ai singoli studi medici.
Il PNRR prevede la realizzazione di centinaia di Case della Comunità sul territorio nazionale, con l’obiettivo di renderle il nuovo punto di riferimento sanitario “di prossimità”.
Ospedali di Comunità
Accanto alle Case della Comunità sono previsti gli Ospedali di Comunità, strutture con un numero limitato di posti letto dedicate a pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero tradizionale, ma non possono essere gestiti del tutto a domicilio.
Servono, ad esempio, per:
- periodi di riabilitazione o stabilizzazione clinica dopo una fase acuta;
- gestione di pazienti cronici complessi;
- supporto a persone anziane che vivono sole o con caregiver in difficoltà.
Si tratta di strutture “intermedie” che permettono di evitare ricoveri ospedalieri lunghi, pur garantendo assistenza sanitaria e infermieristica continua.
Centrali Operative Territoriali (COT)
Le Centrali Operative Territoriali (COT) sono il “cervello organizzativo” della nuova sanità territoriale: coordinano i percorsi dei pazienti, mettendo in comunicazione ospedali, medici di famiglia, servizi domiciliari, strutture intermedie e servizi sociali.
In pratica, dovrebbero evitare che il cittadino e la sua famiglia debbano gestire da soli mille telefonate, prenotazioni, moduli e appuntamenti diversi, rendendo il percorso di cura più semplice e lineare.
La casa come primo luogo di cura: assistenza domiciliare e telemedicina
Un altro pilastro della riforma è l’idea che la casa diventi il primo luogo di cura, soprattutto per gli anziani e per chi ha malattie croniche.
Il PNRR punta molto sulla presa in carico domiciliare e sulla telemedicina: l’obiettivo è aumentare ogni anno il numero di over 65 che ricevono prestazioni a casa, riducendo spostamenti inutili e ricoveri evitabili.
Cosa significa questo, in concreto?
- Più visite domiciliari di infermieri e, dove necessario, di medici.
- Maggiore uso di dispositivi per il monitoraggio a distanza (pressione, saturazione, glicemia, parametri cardiaci, ecc.).
- Possibilità di televisite o consulti da remoto, utili soprattutto per controlli di follow-up.
- Una migliore integrazione tra cartelle cliniche, referti e piattaforme digitali, per evitare ripetizioni di esami e perdita di informazioni.
Se questi strumenti vengono usati bene, la qualità di vita del paziente migliora e anche il sistema sanitario ne beneficia, perché i ricoveri ospedalieri si concentrano sui casi davvero non gestibili sul territorio.
Le nuove figure professionali: l’infermiere di famiglia e comunità
La riforma della sanità territoriale non riguarda solo le strutture, ma anche i professionisti.
Una figura centrale è l’infermiere di famiglia e di comunità, introdotto per essere il punto di riferimento infermieristico per singole famiglie e comunità.
Il suo ruolo è:
- visitare i pazienti a domicilio, monitorare i parametri, istruire sui corretti stili di vita;
- coordinarsi con medici di famiglia, specialisti e servizi sociali;
- intercettare precocemente le situazioni di fragilità (sanitaria, sociale o economica).
In parallelo, si stanno ridefinendo anche i ruoli dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali, che sempre più spesso lavoreranno in équipe multidisciplinari all’interno delle Case della Comunità.
L’idea di fondo è passare da un sistema frammentato, in cui ognuno si occupa di un pezzetto, a un modello integrato dove il paziente è seguito da un team che condivide informazioni e obiettivi.
Opportunità e criticità: a che punto siamo davvero?
Le potenzialità della riforma sono grandi: cure più vicine, tempi di attesa ridotti per molte prestazioni, maggiore attenzione alla prevenzione e alle fragilità sociali, meno “pellegrinaggi” tra uffici e reparti.
Tuttavia, non mancano le criticità:
- Ritardi nella realizzazione delle strutture: molte Case della Comunità e alcuni Ospedali di Comunità sono ancora in fase di attivazione o non offrono l’intera gamma di servizi prevista.
- Differenze tra regioni e territori: alcune aree sono già da anni avanti sulla sanità territoriale, altre arrancano, con il rischio di accentuare le disuguaglianze tra nord e sud, tra città e aree interne.
- Carenza di personale: senza medici, infermieri e operatori adeguatamente formati e in numero sufficiente, anche le migliori strutture rischiano di rimanere scatole vuote.
Perché il cambiamento sia reale, non basta inaugurare nuovi spazi: servono organizzazione, personale, formazione e continuità di finanziamenti.
Cosa cambia per il cittadino: esempi concreti
Per chi vive “vicino a casa”, tutto questo può tradursi in:
- avere un punto sanitario territoriale dove trovare medico, infermiere, sportelli sociali e servizi di orientamento nello stesso luogo;
- poter prenotare esami o visite senza doversi spostare fino al grande ospedale;
- gestire malattie croniche (diabete, BPCO, scompenso cardiaco, ecc.) con piani di cura personalizzati, monitoraggi da remoto e visite di controllo più frequenti ma meno pesanti;
- ricevere assistenza domiciliare strutturata, non solo occasionali visite;
- avere una presa in carico complessiva, che consideri anche la situazione familiare, economica e sociale.
Naturalmente, non tutto questo è già disponibile ovunque. Ma la direzione tracciata è chiara: meno ospedale, più territorio; meno cura episodica, più continuità assistenziale.
Conclusioni: come informarsi e partecipare al cambiamento
La sanità territoriale sta cambiando soprattutto grazie a una combinazione di nuove strutture, nuove figure professionali e nuove tecnologie. La sfida sarà renderla davvero accessibile e omogenea, evitando che resti solo un progetto sulla carta.
Per il singolo cittadino, un primo passo concreto è:
- informarsi sui servizi attivi nella propria zona (sito della ASL/ULSS, sportelli informativi, medici di famiglia);
- chiedere espressamente, quando possibile, percorsi di assistenza domiciliare o in strutture territoriali;
- partecipare agli incontri pubblici e ai percorsi di consultazione quando vengono organizzati a livello locale.
Solo se cittadini, professionisti e istituzioni si muovono insieme, la sanità territoriale potrà davvero trasformarsi in un sistema di cure vicino, continuo e umano, capace di accompagnarci lungo tutto l’arco della vita.